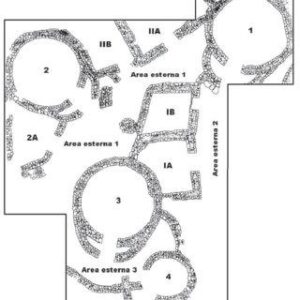Un sistema medico tradizionale può essere definito come un insieme di teorie eziopatogenetiche, diagnostiche e terapeutiche che afferisce ad una specifica cultura e che è stabilmente organizzato intorno ad un nucleo di conoscenze che ha un indiscutibile riconoscimento etnico, nel senso che è ritenuto valido nel contesto di un dato gruppo o di una specifica cultura.
Il problema delle medicine tradizionali si è posto, in Occidente, solo in tempi relativamente recenti. Prima di allora, l’esistenza di medicine diverse da quella occidentale veniva considerata una raffinatezza etnologica o un argomento di disquisizione filosofica.
Le conoscenze mediche sono in realtà un tratto caratteristico della cultura umana ed il livello di raffinatezza dell’arte medica è uno dei parametri più importanti fra quelli che generalmente consentono agli storici di valutare l’evoluzione di una cultura e il suo grado di “civiltà”. Naturalmente, quando “misuriamo” le conoscenze mediche di una cultura, il parametro che utilizziamo è il grado di similitudine con la medicina occidentale moderna.
Si tratta di un parametro errato, che discende dall’idea etnocentrica che la chiave ottimale di lettura della realtà sia quella che afferisce alla tradizione culturale occidentale. Ciò che quindi possiede un buon grado di similitudine con la nostra cultura è buono, mentre è cattivo ciò che se ne differenzia. Noi siamo nel giusto, al centro di un sistema di valutazione che non può che essere esatto quando i risultati che produce.
Allora, da un punto di vista antropologico, considereremo che una società è progredita quando conosce la tecnologia, quando un certo numero di persone guarda il televisore, usa il frullatore e lava i panni nella lavatrice. La norma storica è che, come abbiamo già detto, una cultura subalterna venga valutata in base ai valori della cultura dominante. È la storia di una sopraffazione. Noi occidentali partiamo sempre dal presupposto che un popolo, per essere civile, debba assomigliarci. E allora consideriamo un bene fornire abiti occidentali, pentole di acciaio inox e frigoriferi a popolazioni che non li conoscono. Poco importa che quella data popolazione viva benissimo senza questi “fondamentali” prodotti della nostra cultura. La stessa cosa avviene in campo medico.
La medicina occidentale è attualmente considerata la più progredita in assoluto, è la medicina. In realtà, anche in questo caso, si tende sistematicamente ad ignorare il fatto che in altre culture esistono medicine differenti. O, se non lo si ignora, si classificano come medicine empiriche, prescientifiche o primitive. In realtà, qualunque definizione di un sistema medico, così come di un qualunque sistema scientifico o filosofico, non può prescindere dalla attenta considerazione del contesto culturale nel quale quel sistema è nato e si è evoluto. È da questo stesso punto di vista che vanno valutati i benefici che ha arrecato, la validità delle sue teorie o l’attendibilità delle sue pratiche. Il parametro di misura e di riferimento, insomma, deve essere la cultura nell’ambito della quale un sistema medico si è sviluppato, e non un arbitrario concetto astratto di “medicina scientifica” che è a sua volta il prodotto della cultura occidentale moderna.
La medicina moderna occidentale, per esempio, a fronte di indiscutibili successi, ha smarrito la dimensione umana, il senso del rapporto medico paziente, la capacità empatica che fa del medico un vero e proprio potente farmaco. Ciò significa che manca alla sua terapia un afflato, una capacità di relazione, un modello di rapporto che la rende forse più imperfetta, ma sicuramente più umana. Non inefficace o dannosa. Semplicemente imperfetta. Ed è sull’imperfezione che i sistemi medici differenti dal nostro hanno molto da insegnarci. Essi infatti si fondano sull’imperfezione. A differenza della moderna medicina occidentale, essi non sono perfettibili, bensì tendono a perfezionare l’imperfezione, integrandola all’interno di un sistema di conoscenze che è a sua volta imperfetto e non perfettibile.
Le medicine che differiscono da quella moderna occidentale vengono in genere definite tradizionali, denominazione raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La parola tradizionale deriva dal latino tradere, letteralmente consegnare, da cui traditione, consegna. L’insegnamento tradizionale è quindi quello che si consegna, intatto, da una generazione all’altra, senza modifiche, senza cambiamenti. La caratteristica fondamentale degli insegnamenti tradizionali, è quindi, l’immutabilità. Ciò che si “consegna”, la “tradizione”, è sempre identico a sé stesso e quindi necessariamente imperfetto, in quanto da sempre immodificato. Un sistema medico tradizionale differisce quindi dalla medicina moderna, in quanto ha rinunciato alla perfettibilità e continua ad utilizzare strumenti, tecniche e teorie tramandate di generazione in generazione sin dalla propria preistoria che in taluni casi può coincidere con la preistoria stessa del mondo. È quindi del tutto ovvio che non si tratti di medicine “scientifiche”. E allora, cosa possono insegnare alla medicina occidentale moderna? È semplice: il valore e il significato dell’imperfezione. Un sistema culturale costruisce un mondo, poiché è un modello all’interno del quale è già deciso cosa sia osservabile e cosa non lo sia, cosa sia vero e cosa sia falso, cosa sia credibile e cosa non lo sia. E questo vale per tutti i sistemi culturali. Ciò accade anche in medicina, dove la ricerca della perfezione si è legittimamente orientata in Occidente verso procedimenti tecnologici sempre più complessi e sofisticati (il che è sicuramente un fatto di una importanza straordinaria) ma l’interesse verso questo approccio “scientifico” ha portato a trascurare molti aspetti della realtà individuale e la loro rilevanza sociale: si tratta degli aspetti emozionali, psicologici, esistenziali.
Le medicine tradizionali, nel loro assoluto disinteresse per gli aspetti tecnologici, hanno invece conservato intatto un patrimonio di precetti, idee, atteggiamenti indirizzati verso la dimensione emozionale, soggettiva e culturale.
Questo patrimonio (questo modo di fare medicina) è impossibile da ritrovare nel medico moderno, nell’ambulatorio asettico, nella prescrizione standardizzata di raffinati esami diagnostici o farmaci. Lo si ritrova invece nella gestualità dello sciamano, nel rito terapeutico dell’uomo della medicina, nella somministrazione di piante che sono al tempo stesso farmaco e simbolo, nel rapporto magico ed esclusivo tra il terapeuta stregone ed il suo paziente. Nelle medicine tradizionali, si ritrova quello che può essere chiamato approccio olistico, unitario, al malato. I sistemi medici tradizionali fanno parte intimamente del proprio contesto culturale, ed è ovvio che riflettono nel proprio corpus dottrinario la complessa trama psicologica, esistenziale, religiosa del gruppo nel cui ambito esse si collocano. Il medico tradizionale è un prodotto della propria cultura, adotta gli stessi criteri di classificazione del mondo dei suoi pazienti, lo schema di riferimento entro il quale colloca le sue conoscenze non differisce da quello nell’ambito del quale si collocano le aspettative del paziente e del gruppo sociale. È ovvio, allora, che il sistema medico tradizionale si presenta come specchio di una cultura unitaria, compatta e coerente, in opposizione alla disgregazione che sembra caratterizzare, nella società occidentale moderna, il rapporto tra medico, paziente e cultura.
Le medicine tradizionali, inoltre, sono in qualche modo la sintesi, la quintessenza, non solo delle culture che le hanno originate, ma anche della cultura umana come astrazione. Sono resti archeologici viventi, ed ognuna differisce da un’altra ma, nella stessa misura, tutte hanno in comune un atto terapeutico originario ed immutato, sul quale si fonda la stessa medicina moderna. È quest’atto che accomuna tutti i sistemi medici, a qualunque epoca, a qualsiasi latitudine, per quanto diverse possano essere le loro caratteristiche apparenti. Ed è per questo che ogni sistema medico può arricchirsi attingendo alle conoscenze di altri sistemi medici, e scambiando con essi il proprio sapere.
La caratteristica delle medicine tradizionali è quella di appartenere allo specifico contesto etnico, culturale, religioso e storico di alcune civiltà e culture. Le medicine tradizionali, allora, non sono in contraddizione con la medicina moderna, ma coesistono storicamente con essa, anzi, in certe zone del globo la sostituiscono, la potenziano o la affiancano. Non è un caso che lo studio delle pratiche mediche tradizionali sia, tutto sommato, un’area di indagine abbastanza recente. O, almeno, è recente l’interesse della medicina per così dire “ufficiale” nei confronti di sistemi medici o di pratiche e strategie che, per loro struttura interna e per concezione scientifica, sono diverse dal sistema, dalle pratiche o dalle strategie della medicina moderna. Già nel 1978 l’Organizzazione Mondiale della Sanità si fece di una corretta valutazione dello stato e della fruibilità delle medicine tradizionali, facendole uscire dal limbo della curiosità etnografica.
Esiste da tempo una diatriba internazionale che riguarda la contrapposizione tra interventi ad alto livello scientifico e assistenza sanitaria minima efficace ed è in questa direzione che sembra necessario muoversi, con generale consenso, sul fatto che l’assistenza sanitaria minima «dovrebbe comprendere la sicurezza del parto, la possibilità per i bambini di crescere sani, la conservazione della salute in età adulta, la protezione degli individui e dei gruppi dalle calamità naturali e l’assistenza ai malati».
Ogni cultura da sempre ha provveduto a tali bisogni in maniera autonoma, in base alla propria esperienza medica e ai propri modelli di salute e malattia. È proprio per questo che l’interesse verso l’etnomedicina diviene una necessità nel momento in cui si opera nel contesto di una strategia planetaria. Diviene fondamentale allora valutare con attenzione le risorse effettivamente disponibili, nel tentativo di comprendere quanto grande debba essere l’impegno della medicina moderna occidentale per raggiungere determinati obiettivi e quanto, invece, tali obiettivi possano essere legittimamente assicurati da sistemi medici alternativi. Ma per capire questo bisogna conoscere tali sistemi, studiarne le caratteristiche etnografiche e scientifiche, le potenzialità terapeutiche e preventive, in una parola, la fruibilità.
Si ha l’impressione che la medicina moderna possa imparare molto dalle medicine tradizionali. Ma cosa? Anzitutto una maggiore vicinanza ai bisogni del paziente, che sono, assai spesso, bisogni emotivi che riverberano molto più di quanto non si pensi sulle condizioni fisiologiche, come afferma tra gli altri Lidz. Non a caso il presupposto comune a tutte le medicine tradizionali è la descrizione della vita come unione di corpo, sensi, mente e anima e, conseguentemente, dello stato di salute come armonia del benessere fisico, spirituale, morale e psicologico.
La considerazione del carattere “morale” e di quello spirituale come facenti parte dell’ecosistema dell’individuo è ciò che maggiormente differenzia la medicina occidentale “ortodossa” da quella tradizionale. Nelle medicine tradizionali il concetto di psicosomatico informa tutta la filosofia e la pratica della medicina, in una prospettiva olistica, della salute e della malattia, dove la medicina per essere realmente tale deve essere necessariamente psicosomatica. In un simile contesto culturale è evidente che qualunque forma di medicina debba essere “integrale” non potendo isolare la malattia dal proprio contesto ecologico e socio culturale. È proprio per queste connotazioni delle medicine tradizionali che una straordinaria importanza viene attribuita al rapporto medico paziente: entrambi abitualmente appartengono alla stessa comunità, il che rende possibile che ogni gesto terapeutico sia culturalmente significativo e psicologicamente efficace. Ogni guaritore tradizionale inoltre ha superato quello che definiremmo un training. Egli è solitamente un membro qualunque di una comunità che ha acquisito l’arte terapeutica per vocazione familiare, per tradizione o superando una grave malattia. Fatta la sua scelta, deve sottoporsi ad un lungo ed estenuante noviziato, durante il quale viene a conoscere non solo le modalità tecniche della sua arte ma anche il mondo del mistero, gli oggetti sacri e le esperienze mistiche, in un lungo apprendistato che precede l’iniziazione. Questo lungo periodo di apprendistato permette al guaritore di liberarsi delle proprie tendenze cattive, narcisistiche, sadomasochistiche ed aggressive, consentendogli quindi di sviluppare col paziente, nella pratica, un rapporto terapeutico esemplare, qualunque sia la terapia che egli usa. È assai diverso, rispetto a quello occidentale, l’atteggiamento del medico nei confronti del paziente inteso come unità composta da molteplici caratteristiche. In occidente il rapporto medico paziente è stato per molto tempo un argomento periferico, anche se non pochi studiosi l’hanno riconosciuto per la sua enorme importanza. Ecco quanto, per esempio, scrive Michael Balint, uno dei più acuti studiosi del problema: «Sopra tutto in conseguenza dell’urbanizzazione, un gran numero di persone ha perso le sue radici e i suoi legami, le grandi famiglie con i loro molteplici ed intimi rapporti tendono a scomparire, e l’individuo diventa sempre più solo, anzi isolato. Se si trova in difficoltà, difficilmente egli ha qualcuno a cui rivolgersi per consiglio, conforto, o anche solo per sfogarsi. Egli è obbligato a contare sempre più unicamente sui propri mezzi. Noi sappiamo che in molti individui, forse in tutti noi, qualsiasi sforzo e tensione mentale ed emotiva si accompagna a varie espressioni corporali o è ad esse equivalente».
Le conseguenze di questa tensione esistenziale, com’è noto, possono essere devastanti. E questo è esattamente ciò che fa il medico guaritore nei sistemi medici tradizionali. Cosa possiamo imparare, dunque? Questo considerare il malato e non la malattia, nel contesto di un ecosistema psicologico familiare, tribale, gruppale sociale, in una parola ‘culturale’. Non è poco. Accettare le medicine tradizionali significa rinunciare all’etnocentrismo ed accettare la diversità delle culture umane, nei loro limiti e nelle loro grandezze. Significa fare del mondo la propria patria, o meglio ancora, fare del mondo e della infinità di culture che lo compongono una affascinante terra da esplorare, con curiosità ed umiltà. Significa adeguarsi ad una affermazione del filosofo medioevale Ugo di San Vittore: «l’uomo che trova dolce la sua patria non è che un tenero principiante; colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte; ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero». «È qui, scrive ancora Balint, in questa fase iniziale non ancora organizzata di una malattia, che è decisiva l’abilità del medico nel prescrivere sé stesso.»
Il medico, il terapeuta cioè, non è solo un tecnico in possesso di conoscenze scientifiche e abilità pratica di natura clinica (la diagnosi e la terapia), ma è (o dovrebbe essere) in qualche modo uno “sciamano”, che deve possedere la capacità di gestire un innato potere terapeutico. In tempi di migrazioni di portata biblica, riflettere sulle modalità di interagire con sistemi medici diversi dal nostro, non è solo una disquisizione intellettuale, ma una necessità sociale.
Giovanni Iannuzzo