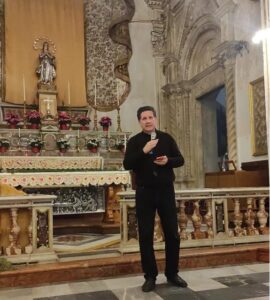Abbiamo già tratteggiato in precedenza la figura del pittore manierista termitano Giuseppe Spatafora II junior (n. 26 Aprile 1603), ultimo rampollo noto di una fiorente casata artistica siciliana, essendo figlio di Antonino Spatafora (Palermo, c. 1552/53 – Termini Imerese, 22 Giugno 1613), architetto civile (capomastro delle fabbriche della cittadina imerese almeno dal 1593-94), militare ed idraulico, pittore, cartografo, scenografo, nonché nipote di Giuseppe Spatafora senior, architetto (capomastro delle fabbriche della città di Palermo dal 1564–65), pittore, scultore e plasticatore. Il corpus delle opere di Giuseppe Spatafora II junior, comincia oggi a delinearsi. Due opere palermitane (Strage dei Santi Innocenti e La Crocifissione dei tre Beati Gesuiti del Giappone, Paolo Miki, Giovanni Soan di Gotó, Giacomo Kisai, per la cappella dei Santi Martiri a Casa Professa, 1654–55), erano note, essendo la loro paternità attestata su base documentaria. Più recentemente al nucleo costituito dalle due opere palermitane, si sono affiancate due dipinti caccamesi attribuiti al nostro artista dallo storico dell’arte Antonio Cuccia (la Madonna in gloria tra S. Stefano Protomartire e S. Lorenzo Martire, della chiesa della Badia e la Santissima Trinità e Santi in Santa Maria degli Angeli). Infine, il primo dipinto scoperto nella sua città natale è stato rintracciato ed attribuiti dagli scriventi (S. Giuseppe col Bambino Gesù in S. Maria di Porto Salvo sotto il titolo di S. Anna).
Il nostro Giuseppe dovette compiere il suo apprendistato presso i due cognati architetti e pittori: Vincenzo La Barbera (Termini Imerese, 1576/77 c. – Palermo 30 Marzo 1642), marito di Elisabetta Spatafora ed il caccamese Nicasio Azzarello (doc. 1613–1623), sposo di Grazia Spatafora. Il 28 Agosto 1638, Giuseppe Spatafora di Termini et habitatore di Palermo, della parrocchia di S. Giovanni li Tartari, sposò nella chiesa parrocchiale palermitana di S. Antonio di Padova, Elisabetta Federico, mentre la benedizione sponsale fu loro impartita in S. Nicolò all’Albergheria (cfr. A. Contino, S. Mantia, Vincenzo La Barbera Architetto e Pittore Termitano. Presentazione di M. C. Di Natale. GASM, Termini Imerese 1998, 150 pp., in particolare, p. 187).
L’artista prediligeva nelle sue opere soggetti a marcata valenza catechetica, caratterizzate da silenti orchestrazioni sceniche dominate da ruderi di strutture architettoniche, oppure scorci urbani quasi metafisici spesso in fuga prospettica che inquadrano umbratili brani paesaggistici con frondose quinte arboree che si aprono esibendo fondali collinari e rocche alpestri. Si tratta, di richiami derivati da modelli desunti dal paesaggismo nordico, allora molto in voga e, in particolare, dai dipinti e dalle stampe dell’artista di origine fiamminga Paul Bril (1554 – 1626) o del suo entourage. L’ambientazione scenica dei dipinti dell’ultimo rampollo di casa Spatafora, appare avvolta in una sorta di “sospensione temporale” che esalta il senso di decadenza, accentuato dai ruderi architettonici e, talvolta, da cupi contesti meteorologici. Particolare attenzione mostra il nostro artista nel deciso contrasto tra le ombre rese corpose e le luci sapientemente marcate, che si intensifica nelle più mature opere palermitane, esaltando la tridimensionalità delle figure.
A questo scarno corpus di opere di Giuseppe Spatafora II junior riteniamo debba aggiungersi un’altra tela, dipinta ad olio che, a nostro giudizio esibisce le medesime coordinate culturali e che si conserva proprio nella città natale. Il dipinto in questione, che qui, per la prima volta, proponiamo di attribuire al pennello del minore degli Spatafora, tratta un soggetto iconografico ampiamente diffuso nella pittura del Seicento, cioè il tema sacro della Immacolata Concezione di Maria SS. L’opera è attualmente esposta presso il museo civico di Termini Imerese, provenendo dall’importante lascito del pittore, storico dell’arte e direttore di detta struttura museale, il termitano cav. Ignazio De Michele e De Michele (1810-1888), che magnanimamente volle che fosse acquisita la sua variegata collezione privata.
Allo stato attuale delle ricerche, la fonte più antica che menziona, sia pure en passant, questa tela è Giuseppe Patiri, il quale nel citare le opere conservate nel museo civico termitano, rammenta senza descriverlo «un dipinto dello Zoppo di Ganci» (cfr. G. Patiri, Termini Imerese Antica e Moderna, Stab. Tip. a vapore Fratelli Marsala, Palermo 1899, 120 pp., in particolare, p. 75). Del resto, la medesima attribuzione della nostra tela appare anche negli inventari della struttura museale, essendo infatti riferita proprio a Giuseppe Salerno, uno dei due pittori manieristi noti con lo pseudonimo di “Zoppo di Gangi”. L’attribuzione deriva precipuamente da certe reminiscenze che riecheggiano le tele del Salerno, soprattutto del primo quindicennio del Seicento; però, a parte le affinità tematiche e stilistiche, appare manifesto che il dipinto termitano è lontanissimo dall’espressività della produzione autografa del gangitano e ciò ci induce a rigettare decisamente la vecchia ipotesi attributiva ottocentesca ritenendola del tutto inconsistente. Del resto, l’attribuzione al Salerno, era legata alle conoscenze del tempo ed alla notorietà dell’artista madonita e ciò aveva orientato la critica ottocentesca verso il gangitano, tanto più che il nostro Giuseppe Spatafora II junior era praticamente misconosciuto, mentre oggi nuove prospettive sono intervenute, orientandoci proprio verso l’ultimo rampollo della casata artistica degli Spatafora.
In una scarna recente scheda, relativa a questa opera, redatta dalla studiosa Anna Virzì, la tela è riferita ad un ignoto artista della prima metà del secolo XVII, senza ulteriori specificazioni d’ambito, menzionando sommariamente come possibile fonte d’ispirazione una delle «tante incisioni in circolazione». In aggiunta, la Virzì ritiene che le «due schiere angeliche che circondano la Vergine», sarebbero «vicine per certi aspetti, ma con le dovute differenze stilistiche e formali» a quelle dell’omonimo soggetto del 1627 di Pietro Novelli per la cappella di giuspatronato della casata dei Bruno (poi pervenuta ai Solìto, committenti dell’opera) in S. Maria di Gesù-La Gancia, attualmente esposto nello stesso museo civico (cfr. A. Virzì, Pittura del XVII secolo a Termini Imerese, GASM, Termini Imerese 2004, scheda n. 26, pp. 118–119).
Le dimensioni relativamente contenute ed il tema effigiato nella tela, Immacolata Concezione di Maria SS., farebbero propendere per una committenza devozionale in ambito privato, cosa alquanto plausibile vista la provenienza dalla quadreria di casa De Michele. Allo stato attuale delle ricerche, non è noto né da chi né quando l’opera fu commissionata all’autore che, con il suo estro, interpretò e riprodusse sulla tela il messaggio catechetico–devozionale della concezione virginale di Maria, fondata sulla S. Scrittura (Genesi, 3, 15; Luca, 1, 28) ed ampiamente confermata dalla tradizione cristiana sia latina, sia greca (cfr. Eadmerus, Tractatus de conceptione sanctae Mariae, Herder, Friburgi Brisgoviae 1904, XL+104 pp.; A. Ballerini, Sylloge monumentorum ad mysterium Conceptionis Immaculatae Virginis Deiparae illustrandum, 2 voll., apud Jacobum Lecoffre et socios, Romae 1855-1857, I, XCII+III+573 pp.; II, 830 pp.; A. Schaefer, Die Gottesmutter in der Heiligen Schrift. Biblisch-theologische Vorträge, Münster 1887, X+260 pp.; G. Arendt, De protoevangelii habitudine ad immaculatam deiparae conceptionem analysis theologica, Ex Off. Typ. Artificum A S. Joseph, Romae 1904, XII+230 pp.; Th.-M.-J. Gousset Archevêque de Reims, La croyance générale et constante de l’Église touchant l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie prouvée principalement par les constitutions et les actes des papes, par les lettres et les actes des évêques, par l’enseignement des pères et des docteurs de tous les temps, Jacques Lecoffre et C.ie, Paris 1855, XVI+820 pp.; Th. Livius, The blessed Virgin in the Fathers of the first six centuries, Burns and Oates, London 1893, XXVIII+482 pp.; E. Neubert, Marie dans l’Église anténicéenne, Gabalda, Paris 1908, 280 pp.; M. Jugie, L’Immaculée-Conception dans l’Écriture Sainte et dans la tradition orientale, Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, 3, Office du livre catholique, Rome 1952, 490 pp.). La festa liturgica della Conceptio sanctae Mariae diffusa in Oriente, fu introdotta nell’Italia meridionale attorno al IX secolo. A Napoli un calendario liturgico marmoreo pone la festività il 9 dicembre (cfr. S. De Fiores, Il dogma dell’Immacolata Concezione. Approccio storico-teologico dal Quattrocento al Settecento, in G. Morello, V. Francia, R. Fusco, Una donna vestita di sole…cit., p. 22).
Del resto, questo soggetto ebbe una notevole diffusione nel campo delle arti visive, soprattutto nei domini spagnoli, in relazione alla devozione verso l’Immacolata Concezione, sin dalla seconda metà del Quattrocento. Tale devozione si estese anche attraverso diverse iniziative da parte della corona, di concerto con il papato, dapprima di riconoscimento del culto e, successivamente, volte alla promulgazione del dogma. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo il lettore alla seguente bibliografia essenziale: S. Stratton, La Inmaculada Conceptión en el arte espanol, “Cuadernos de arte e iconografía”, Tomo I- 2, Fundación Universitaria Española, Madrid 1988, pp. 3-128; G. Morello, V. Francia, R. Fusco, Una donna vestita di sole: l’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri, Catalogo della mostra, Roma, 12 Febbraio-13 Marzo 2005, F. Motta, Roma 2005, 312 pp.; A. Anselmi, a cura di, L’immacolata nei rapporti tra l’Italia e la Spagna, De Luca, Milano 2008, 544 pp.
Nel Seicento, lo sviluppo del culto e dell’iconografia raggiunse l’apice della diffusione nei domini ispanici, tanto da indurre i curatori di una dettagliata indagine, a definirlo «el siglo de la Inmaculada Conceptión» (cfr. M. Martinez Alcalde, S. Yago Soriano, J. J. Ruiz Ibañez, cur., El Siglo de la Inmaculada, Vestigios de un mismo mundo, 12, Universidad de Murcia, Murcia 2018, 570 pp.). Del resto, nel 1616 per perorare l’approvazione del culto, grazie anche all’attività diplomatica spagnola presso la Santa Sede, nacque la Real Junta de la Inmaculada Conceptión [cfr. J. Meseguer Fernandez, La Real Junta de la Inmaculada Conceptión (1616-1817/20), “Archivo Iberoamericano”, XV, 1955, pp. 621-686]. L’anno seguente, la Monarchia Cattolica introdusse il votum sanguinis, il giuramento pubblico di fedeltà all’Immacolata Concezione per tutti i ministri del sovrano che, successivamente, fu esteso in tutti i domini asburgici, dalle università degli studi alle municipalità, dalle confraternite agli ordini cavallereschi (cfr. M. Meluzzi, G. Sabatini, F. Tudini, a cura di, La Vergine contesa: Roma, l’Immacolata Concezione e l’universalismo della Monarchia Cattolica (secc. XVII-XIX), Studi e ricerche – Università Roma Tre, Dipartimento di Studi umanistici, Area di studi storici, geografici, antropologici, 38, Viella, Roma 2022, 466 pp.). Papa Alessandro VII (al secolo il senese Fabio Chigi Marsili, 13 Febbraio 1599 – Roma, 22 Maggio 1667) con la bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum del giorno 8 Dicembre 1661, rinnovò i decreti favorevoli alla devozione verso l’Immacolata Concezione, già concessi da Sisto IV, Paolo V e Gregorio XV, essendo pienamente conscio della vetustà e della diffusione nella Chiesa cattolica.
Per completezza di informazione, ricordiamo che, finalmente, a coronamento di un plurisecolare percorso non privo di alterne vicende, la definizione dogmatica fu pronunziata da Pio IX nella bolla Ineffabilis Deus del giorno 8 Dicembre 1854, con la quale si dichiarava «dottrina cattolica rivelata da Dio» il privilegio, tutto proprio della Vergine Maria, «di essere stata, fin dal primo istante del suo concepimento, in vista dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, preservata immune da ogni macchia del peccato originale». Per ulteriori approfondimenti rimandiamo il lettore alla seguente bibliografia, in parte disponibile on-line: V. Sardi, La solenne definizione del dogma dell’immacolato concepimento di Maria SS. Atti e documenti pubblicati nel cinquantesimo anniversario della stessa definizione da mons. Vincenzo Sardi, 2 voll., Tip. Vaticana, Roma 1904-5, I, X+964 pp., II, 724 pp.; P. Tacchi Venturi, Gli atti e documenti della definizione dell’Immacolata, “Civiltà Cattolica”, IV, 1905, pp. 52-63; G. Perrone, De Immaculato B.V. Mariae Conceptu an dogmatico decreto definiri possit disquisitio theologica Ioannis Perrone, Ioannes Marini et Bernardus Morini, Romae MDCCCXLVI, VIII+278 pp.; J-B. Malou, L’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie considérée comme dogme de foi, H. Goemaere, Bruxelles 1857, XXVIII+436 pp.; W. B. Ullathorne, The immaculate conception of the Mother of God, 2ª ed., Art and Book Co., Westminster MDCCCCIV, IX+ 223 pp.; A. M. Lepicier, Tractatus de B. V. Maria matre Dei, II, P. Lethielleux, Parisiis 1901, XXXII+484 pp.; X.-M. Le Bachelet, L’immaculée conception, Science et Religion, Blod et C.ie, Paris 1909, 140 pp.; S. M. Cecchin, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dogma, Pontificia Accademia Mariana Internazionale, Roma, Città del Vaticano, 2003, IX+248 pp.). Da notare che ventiquattro anni prima della proclamazione del dogma, il 27 Novembre 1830, la mistica Zoe Labouré (Fain-lès-Moutiers, 2 Maggio 1806 – Parigi, 31 Dicembre 1876), allora novizia nel monastero della Compagnia delle Figlie della Carità sito in Rue du Bac, poi divenuta suora con il nome di Catherine Labouré, canonizzata nel 1947 da papa Pio XII, aveva avuto una visione della SS. Vergine Maria nella quale tra l’altro era apparsa la preghiera «O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che abbiamo ricorso a Voi» (Ȏ Marie, conçue san péché, priez pour nous qui avons recours à vous), ricevendo l’incarico di far coniare una apposita medaglia come poi avvenne due anni dopo, avendo ottenuta l’autorizzazione dall’arcivescovo di Parigi, Monsignor Hyacinthe-Louis de Quélen (Paris, 8 Ottobre 1778 – ivi, l31 Dicembre 1839). Quattro anni dopo la proclamazione del dogma, il 25 Marzo 1858, la mistica Marie Bernarde (Bernadette) Soubirous (Lourdes, 7 Gennaio 1844 – Nevers, 16 Aprile 1879), poi religiosa francese, proclamata santa da papa Pio XI nel 1933, riferì che nella sedicesima apparizione nella grotta di Massabielle, sui Pirenei, la SS. Vergine si era presentata a lei dicendo: «Sono l’Immacolata Concezione» (nella lingua locale, l’occitano: Que soy era Immaculada Councepciou).
Tornando al dipinto termitano, la tela del civico museo, dal punto di vista teologico e iconografico si ricollega chiaramente alla diffusione nell’orbe cattolico della grande devozione nei confronti dell’Immacolata Concezione che, come abbiamo visto, ebbe il suo apogeo proprio nel Seicento. L’olio raffigura la SS. Vergine Maria Immacolata, in una collocazione centrale in seno all’orchestrazione scenica, all’impiedi, posta frontalmente, nella sua armoniosa bellezza spirituale, in una atmosfera di sospensione spazio-temporale, avvolta da una raggiera di luce dorata (ocra) quale «donna vestita di sole» (mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim, Ap. 12,1), che si intensifica con una vivida luminosità attorno al capo scoperto e coronato da dodici stelle. L’alone di luce dorata si riflette sulle figure di angioletti che circondano la Vergine creando forti contrasti chiaroscurali.
La Vergine, in atteggiamento contemplativo, rivolge gli occhi, verso l’alto in direzione della bianca colomba che si libra sopra di Lei, simboleggiante lo Spirito Santo. Maria SS., infatti, è perenne Santuario ineffabile dello Spirito Santo, il quale in Lei «voleva operare la concezione e la nascita di Colui dal quale egli stesso procedeva» (cfr. S. Anselmo, De Conceptu Virginali, cap. XVIII). Nel contempo, Ella è Colei che diede il suo cordiale assenso alla sua virginale concezione del Salvatore: «Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc. 1,38). Le braccia della Vergine sono spalancate e le mani aperte in un atteggiamento di amorevole accoglienza. Ella indossa una tunica rossastra lunga sino ai piedi, chiusa in vita da una cintura ed un ampio e lungo mantello bluastro, colori tradizionali volti a simboleggiare che, pur avendo la natura umana, ha ricevuto il singolare privilegio della pienezza della grazia celeste, della purezza della vita divina.
In questa opera, la figura di Maria, appare effigiata ritta sul globo terracqueo sostenuto da tre cherubini che nel reggere il grave esibiscono torsioni e caratteristiche movenze. La Vergine schiaccia sotto i piedi la testa del serpente demoniaco (cfr. il protovangelo, in Genesi 3, 15) ed è accompagnata dalla falce lunare con le punte rivolte in alto. La luna, quale astro che non splende di luce propria, ma riflette quella che riceve dal sole, simboleggia Maria Santissima, riflesso della perfezione divina. Tra le nubi, a formare un ovale in una coralità intorno alla figura centrale, appaiono degli angioletti festanti che recano vari simboli di matrice mariana: la palma (alludente alla redenzione, cfr. E. Kirschbaum, a cura di, Lexikon der christlichen Ikonographie, 8 voll., Freiburg, 1971, III, col. 364-365); serti di rose (Rosa Mistica); i gigli, emblemi per eccellenza dell’Annunciazione, etc.
Nel registro inferiore della tela si apre un paesaggio sul quale incombe un cielo nuvoloso. Il panorama, dagli spunti nordici, ricco di contrasti chiaroscurali che fanno risaltare la silhouette delle strutture architettoniche inserite in un luogo immerso in un’aurea di sospensione temporale, è elaborato espressamente per suscitare nel fedele la contemplazione, la meditazione e la preghiera, relativamente ai misteri mariani.
Nello specifico, da sinistra a destra (dello spettatore), nel paesaggio sono presenti i seguenti simbolismi mariani: 1. Una scalinata che sale sino alla sommità di una rupe rocciosa, a rappresentare Maria quale mistica scala, attraverso cui «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv. 1,14); 2. La Porta del Cielo (Janua Coeli, Gen. 28,17), raffigurata sotto forma di una grande arcata coronata da una trabeazione spezzata, che si staglia sul cielo, al culmine della scalinata, alludente alla Vergine che, con materna protezione e tenerezza accompagna, il fedele nel suo cammino verso la patria celeste; 3. Una sorgente zampillante sgorga dalla rocca, riversando le sue traboccanti acque, allusione alla purezza di Maria della sua vicinanza a Dio (Fons hortorum, Ct. 4,15); 4. La vera dalla forma ovale, sormontata da una elegante struttura metallica, raffigura il pozzo delle acque vive (Puteus aquarum viventium, Ct. 4,15), richiamo al limpido candore della Vergine ed alle grazie che Ella dispensa; 5. Un tempio circolare coronato da una cupola, ornato esternamente da colonne, simboleggia Maria come Tempio dello Spirito Santo (Templum Spiritus sancti, cfr. I Cor. 6,19), essendo Ella totalmente e perennemente avvinta allo Spirito Santo; 6. Il giardino sacro recintato (Hortus Conclusus, Ct. 4, 12) simboleggia l’inviolabile purezza e, quindi, la perenne verginità di Maria SS.; 7. La Torre di Davide (Turris Davidica, cfr. Ct. 4,4), svetta al di sopra di una salda base rocciosa, terminando con una guglia, quale prefigurazione della Vergine Maria: «Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza», simbolo di bellezza e fermezza nella fede; 8. Una grande città, con tanto di fortezza, allude alla Vergine Maria, mistica città di Dio.
La fonte principale di ispirazione di questo dipinto, che non è stata pedissequamente seguita dall’artista, il quale ha liberamente e variamente reinterpretato la scena (ad es. modificando la posa della Vergine) secondo il proprio estro artistico, è stata da noi rintracciata e viene qui resa nota per la prima volta. Si tratta di una incisione calcografica del 1615, di cui esiste copia di proprietà dell’Accademia dei Lincei, raffigurante L’Immacolata Concezione, opera dell’incisore francese (di Troyes) attivo a Roma, Philippe Thomassin (b. 1562 – 1622), tratta da un dipinto del pittore genovese Bernardo Castello (1557 c. – 1629). A tal proposito, si veda nel sito dell’Istituto Centrale per la Grafica del Ministero dei Beni Culturali. Per completezza di informazione, ricordiamo che lo stesso soggetto fu inciso anche da Raffaello Schiaminossi da Sansepolcro (1572-1622). L’autore del dipinto, inoltre, ha utilizzato anche un’altra incisione calcografica di Thomassin, realizzata a bulino, sempre raffigurante L’Immacolata Concezione, datata 1591, traendo ispirazione per riprodurre la simbologia mariana inserita nel brano di paesaggio. Per ulteriori approfondimenti sull’incisore Thomassin, cfr. A. Gallottini, a cura di, Philippe Thomassin. Antiquarum statuarum Urbis Romae Liber Primus 1610-1622, “Bollettino d’Arte”, volume speciale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Archivi di Stato, Roma 1995, XV+173 pp.
Il confronto tra la tela in oggetto, le due opere documentate e le tre sinora attribuite, evidenzia marcate coincidenze espressive nella costruzione pittorica, legate ad un comune lessico, incisivo ed immediato, nonché una voluta accentuazione delle figure nei valori tonali e luministici. Infatti, l’orchestrazione luministica è qualificata da forti contrasti chiaroscurali, con le ombre rese in maniera corposa, in modo da esaltare plasticamente l’essenzialità delle figure, dando altresì origine ad una sorta di sospensione spazio-temporale. Anche l’orchestrazione del brano di paesaggio posto nel registro inferiore presenta marcate corrispondenze con le opere già note, esibendo una comune predilezione per il gusto antiquario (con le consuete rovine della romanitas, quali capitelli e rocchi di colonne), ma anche per gli aspetti naturalistici, come ad es. appare nella resa di sproni rocciosi più o meno alpestri, della vegetazione rigogliosa, del peculiare contesto meteorologico, con frequenti richiami alla pittura nordica di genere.
L’autore di questo dipinto, a nostro avviso, era legato alla cerchia labarberiana (si veda ad es. la resa degli angioletti che reggono il globo), pertanto possiamo avvedutamente ritenere che si tratti di un allievo che ha ben assimilato la lezione del maestro, facendola propria secondo la sua personale sensibilità artistica. Un allievo sodale con il maestro, tanto da assimilare anche la propensione per la ricerca di variegate fonti di ispirazione, l’ampio raggio di interessi ed il disinvolto sperimentalismo, attraverso l’uso di incisioni di artisti della tarda maniera, con una particolare predilezione per quelli europei centro-settentrionale.
Concludendo, riteniamo che il dipinto, raffigurante L’Immacolata Concezione di Maria SS., che abbiamo qui illustrato, debba aggiungersi all’esiguo catalogo di Giuseppe Spatafora II junior. Questo studio appartiene ad un filone di ricerca che si prefigge la riscoperta delle opere sconosciute o misconosciute degli artisti termitani, costituendo un contributo alla ricostruzione del percorso artistico di Giuseppe Spatafora II junior, la cui cifra stilistica, pur essendo non eccelsa, a nostro avviso, si presenta indubbiamente dignitosa.
Patrizia Bova e Antonio Contino
Ringraziamenti: vogliamo palesare la nostra più viva e sincera gratitudine nei confronti dell’amico Fabio Lo Bono, per la consueta disponibilità e per l’immagine fotografica del dipinto.