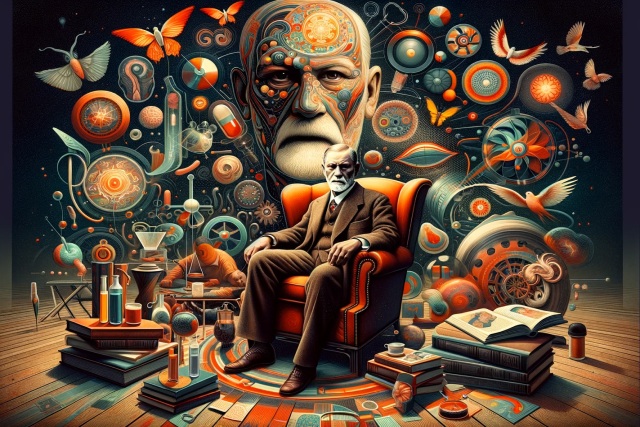In una notte dell’ottobre 1895, un medico trentanovenne di origine morava ma residente sin dall’infanzia a Vienna “buttò giù”, una curiosa bozza di lavoro scientifico. Il termine “curioso” è forse l’unico utilizzabile vista la natura e i contenuti specifici del testo in questione, e dell’epoca. In quello scritto si sosteneva, fra l’altro, una lettura rigorosamente neurobiologica e neuropsicologica dei processi mentali, fondata su concetti fisici come quello di inerzia, cariche che “riempiono” o “svuotano” la cellula nervosa, recettori, sostanze endocrine, effettori; e vi veniva descritta una teoria neuronale di straordinaria modernità. Quella bozza inoltre conteneva la prima elaborazione teorica di concetti fondamentali come quello di feedback e di feedforwald, che si sono rivelati fondamentali non solo per l’analisi di sistemi biologici complessi, ma anche per lo studio di sistemi omeostatici di ogni ordine e tipo e, infine, per la stessa programmazione informatica. Il termine feedback sta ad indicare una “retroazione”: il centro operativo di un sistema invia una comunicazione verso la periferia e: questa comunicazione ritorna poi alla sua sorgente dando informazioni sugli effetti che la comunicazione stessa prodotti dalla comunicazione in periferia o sul destinatario. Il termine di feedback è utilizzabile sia in campo fisico che neuropsicologico, che comportamentale. Una persona che parla e sente le proprie parole ha un feedback uditivo. Ma meccanismo di feedback, a livello biologico, è anche, per esempio, l’aumento o la diminuzione della secrezione di ormoni in base al loro livello del sangue. Il termine feedforwald indica invece una “proazione”, ovvero un processo lineare e non circolare di attività predisposte in relazione a percorsi predeterminati. Un esempio di feedforwald potrebbe essere dato dal condizionatore che continua a funzionare per periodi fissi, indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente.
Nel testo febbrilmente elaborato da Freud infine veniva posta una decisa differenziazione tra concetti come energia e informazione, una distinzione che si rivelerà fondamentale per la comprensione di ogni processo psicologico: da una prospettiva ovviamente biologica. La bozza elaborata febbrilmente da quel medico rappresenta dunque la summa di tutto quello che sarebbe poi diventata la struttura teorica basilare delle neuroscienze. Quel medico si chiamava Sigmund Freud. Egli stesso ha descritto così, in una lettera del 20 ottobre 1895 all’amico Wilhelm Fliess quel particolare momento creativo: “…in uno di quei momenti di penoso disagio in cui il mio cervello lavora meglio, le barriere improvvisamente si sono sollevate, i veli sono caduti e sono riuscito a vedere tutto, dai dettagli delle nevrosi fino alle condizioni della coscienza. Ogni cosa al suo giusto posto, gli ingranaggi a posto, si trattava di una macchina che, da un momento all’altro, avrebbe cominciato a muoversi da sola”.
Ma la macchina, in verità, non si mosse. Non era la prima volta che il geniale e tormentato medico ebreo prendeva un abbaglio, anzi, sino ad allora la sua carriera era stata riccamente costellata di scivoloni scientifici. Laureatosi nel 1881, coltissimo, competente e ambizioso, Freud aveva cercato di trovare la sua strada in vari modi, facendo leva sulla sua formazione di biologo e di ricercatore. Nel 1884 aveva intrapreso la via della psicofarmacologica, non senza successo: scopritore ‘clinico’ delle potenzialità psicotrope della cocaina, della quale aveva descritto brillantemente gli effetti comportamentali e farmacologici, aveva poi esagerato ritenendola una sorta di panacea universale, sino a consigliarla come ricostituente alla fidanzata Martha, e venne duramente criticato dagli ambienti scientifici ortodossi, al punto che decise di dedicarsi ad altro (ne ho già diffusamente parlato in un passato articolo su questa stessa rivista). Dopo un breve, ma illuminante, soggiorno di studi alla Salpêptrière, l’ospedale psichiatrico di Parigi diretto dal neuropsichiatra francese Charcot, aveva intravisto l’importanza della sessualità come fattore eziologico, o addirittura eziopatogenetico, nei disturbi nervosi, e sulla scia di questa “scoperta” nel 1889 aveva pubblicato insieme all’amico e mentore Joseph Breuer i famosi Studi sull’isteria, contenenti alcune importanti nuove intuizioni. Ma, così come il suo rapporto con Breuer, presto naufragarono le sue ambizioni cliniche. Ora, alla luce del suo rapporto con Wilhelm Fliess, otorinolaringoiatra e buon orecchiante di psicopatologia, aveva trovato qualcosa d’altro. Ma stavolta qualcosa di davvero importante: un Progetto di psicologia scientifica. Di fatto, però, Freud abbandonò il Progetto subito dopo averlo elaborato. Una serie di nuovi eventi (la scoperta del trauma infantile, dei meccanismi della seduzione e gli approfondimenti teoretici clinici che ne derivarono) e motivi personali sembrano alla base di questa “rimozione”. Di fatto, la sua febbrile teoria neurologica rimase sullo sfondo della sua opera, anche dopo l’invenzione della psicoanalisi, tanto da far dire a James Strachey che «…il Progetto, o meglio il suo invisibile fantasma, aleggia sulla serie degli scritti teorici di Freud dal principio alla fine».
Eppure Freud non fu mai particolarmente tenero nei confronti del suo importante parto scientifico. Lo dimostrerebbe un fatto storico singolare. Le sue lettere a Fliess, rimaste inedite sino a tempi recenti, furono da quest’ultimo conservate sino alla sua morte, nel 1928. La vedova le vendette a un libraio di Berlino, ma a condizione che non le cedesse mai a Freud, perché era convinta che questi le avrebbe sicuramente distrutte. Quando infatti la principessa Marie Bonaparte, dello strettissimo entourage freudiano le acquistò per la cifra non proprio irrilevante di quattrocentottanta dollari e Freud lo venne a sapere, le raccomandò di bruciarle. «Non voglio», le disse, «che alcuna di esse possa venir conosciuta dai cosiddetti posteri». È una fortuna che la Bonaparte non abbia ubbidito. Le lettere finirono poi, per sfuggire alla delirante iconoclastia nazista, in una banca viennese e da qui all’ambasciata danese. Alla fine della guerra furono trasferite in Inghilterra (ultima patria di Freud) e lo furono in maniera particolare. Poiché nella Manica c’erano ancora mine, tutti i documenti furono avvolti in materiale galleggiante e impermeabile: se la nave fosse affondata, i manoscritti avrebbero continuato imperterriti la loro navigazione, quella reale nelle acque della Manica e quella metaforica lungo i mari della storia. Non avvenne. Gli scritti di Freud furono religiosamente conservati negli archivi psicoanalitici inglesi. Erano lettere e minute, ed una di queste era proprio il Progetto, del quale Walter A. Stewart scrive: «Una di queste minute è un manoscritto di cento pagine, senza titolo, che i curatori degli Anfange hanno intitolato “progetto di una psicologia scientifica”. Si tratta di un documento in sé straordinario che Freud scrisse nel 1895 con una intensità febbrile e una grande speranza, ma che abbandonò nel giro di pochi mesi considerandolo uno sforzo inutile. La maggior parte degli scritti di Freud deve essere letta paragrafo per paragrafo, ma di questo documento si può senz’altro dire che deve essere letto e riletto frase per frase e persino parola per parola. Esso contiene le riflessioni di Freud più elaborate e complesse e costituisce la base di molti concetti fondamentali che egli sviluppò nei restanti quarantadue anni della sua vita usando una terminologia differente».
Che cosa accadde, in realtà? Probabilmente Freud si era accorto si essere andato troppo avanti, in un momento storico in cui neuropsicologia e neurobiologia erano scienze in fieri, o di là da venire. Come scrivono in un brillante saggio Pribram e Gill: «Egli sentiva che la conoscenza richiesta per fornire un substrato organico ai suoi concetti metapsicologici non era ancora disponibile ma che lo sarebbe stata in qualche tempo a venire. Le sue idee circa un tale substrato sono di due tipi, neurologiche e biologiche. Sul piano neurologico l’accento cade sull’energia e sulle sue varie qualità. Delle due idee base del Progetto – quella relativa alla quantità e quella della teoria dei neuroni – Freud continua a conservare quella attinente alla quantità e alle sue varie forme sebbene non utilizzi più il modello della teoria dei neuroni».
D’altra parte esistono ampie testimonianze nell’opera di Freud del mantenimento delle idee originarie, esposte nel “Progetto”. Come quando dice: «Dobbiamo rammentare… che tutte le nozioni psicologiche che noi andiamo via via formulando dovranno un giorno essere basate su un sostrato organico. Ciò rende probabile che a rendere operante la funzione sessuale siano alcune sostanze e processi chimici particolari i quali provvedono alla prosecuzione della vita individuale in quella della specie…». È probabilmente uno dei fatti più curiosi della scienza del Novecento che l’artefice del più lungimirante costrutto teorico neurobiologico della psichiatria moderna sia stato, quasi contemporaneamente, il suo più implacabile revisionista. Per motivi non ancora del tutto chiari, Freud passò da una concezione della mente sperimentale e organicistica a una concezione puramente descrittiva, “psicologica”; anzi è stato l’artefice della negazione della stessa teoria che aveva elaborato, tanto da giustificare l’opinione dei biologi sul fatto che la psicoanalisi, come scrivono Pribram e Gill, sembra «pervasa dallo spirito di un’azienda che non assume se non personale non scientifico». Sono dovuti trascorrere decenni, in effetti, perché le tendenze “descrizioniste” di Freud (poi riprese da tutte le correnti della psicologia contemporanea, anche di altri indirizzi e orientamenti) ritrovassero la strada originaria, smentendo il Freud psicologo (figlio) che le aveva apparentemente smentite, riconfermando potentemente il Freud neurologo (padre) che aveva inizialmente adottato altri modelli. È un caso che il Complesso di Edipo tanto importante nella teoria freudiana, sia un conflitto tra padre e figlio per il possesso della stessa donna, che in questo caso sembrerebbe la conoscenza? «Proprio perché in genere mi sforzo di tener lontano dalla psicologia tutto ciò che è estraneo alla sua natura, incluso il pensiero biologico, desidero a questo punto ammettere espressamente che l’ipotesi di una separazione fra pulsioni sessuali e pulsioni dell’Io – e cioè la teoria della libido – non poggia che in misura minima su basi psicologiche e ha invece nella biologia il suo supporto essenziale».
In realtà, non sarebbe un errore descrivere la psicoanalisi freudiana come una psicobiologia imperfetta, qualitativa. Vi si riscontrano tutti i principi della scienza neurobiologica di allora: dal paradigma stimolo-risposta alla causazione meccanicistica della psicofisiologia, alla legge del tutto o nulla, alle concezioni idrauliche, ai principi della termodinamica. Vi sono riferimenti, fra l’altro, a concetti quali il livello di soglia di eccitazione, quasi identico a quello che poi sarebbe stato il concetto di eccitabilità della membrana nervosa stimolata da un impulso elettrico di quantità definita.
L’episodio del Progetto di una psicologia, fa di Freud un pioniere degli studi sulla biologia dei processi psichici, ma le sue ipotesi e le sue formulazioni si inscrivono in una corrente di pensiero e di riflessioni che sarebbe arrivata molto più lontano di quanto lo stesso Freud avesse forse mai immaginato.
Giovanni Iannuzzo